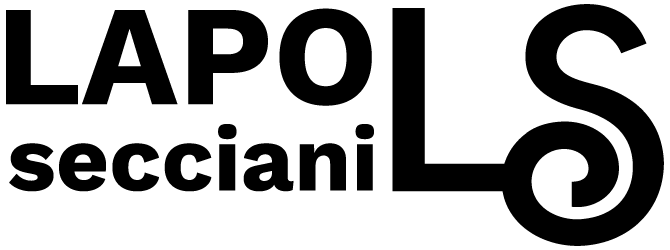Le città contemporanee hanno progressivamente smarrito la loro essenza di luoghi di vita condivisa, diventando troppo spesso spazi progettati per separare più che per unire. Abbiamo riempito il territorio di edifici monofunzionali e isolati che, terminato il loro orario d’uso, si svuotano e smettono di vivere. Così facendo abbiamo prodotto vuoti urbani, spazi senza anima né relazione, che generano solitudine sociale e diventano terreno fertile per il degrado e il senso di insicurezza. Ma le città non sono fatte solo di pietra e cemento: sono fatte di relazioni, di incontri, di vita quotidiana che scorre negli spazi e li trasforma in luoghi vissuti e riconosciuti.
Occorre un cambio di paradigma profondo e concreto. Serve progettare e costruire ecosistemi urbani vivi e condivisi, dove le persone possano trovare tutto ciò che serve per vivere bene: lavoro e tempo libero, cultura e sport, servizi e spazi di relazione. Luoghi dove crescere come individui, come cittadini e come professionisti, dove la qualità degli spazi diventa anche presidio spontaneo di sicurezza. Non per la presenza di controlli e barriere, ma per la vitalità delle persone che li abitano e li curano ogni giorno.
La città del futuro sarà policentrica, fatta di quartieri compatti e raggiungibili a piedi o in bicicletta, in cui abitazioni, servizi, cultura e verde pubblico convivono armonicamente. Non quartieri dormitorio da attraversare in auto, ma luoghi che vivono ogni ora del giorno, capaci di alternare attività economiche, sociali e culturali che si intrecciano lungo la giornata e la settimana.
Luoghi dove la presenza continua di persone e attività genera sicurezza naturale e diffusa, fatta di relazioni, di attenzione reciproca e di presidio spontaneo.
Perché, come insegna Jan Gehl, una città fatta per le persone è una città più sicura, più sana e più felice.
In questa visione si inserisce il superamento dell’edificio mono funzione. Per troppo tempo abbiamo progettato contenitori rigidi, incapaci di adattarsi ai cambiamenti della società e dei bisogni quotidiani.
Edifici scolastici chiusi nel pomeriggio, uffici deserti la sera, palestre vuote nei fine settimana. È tempo di progettare spazi reversibili, multifunzionali e flessibili, capaci di cambiare destinazione d’uso nel corso della giornata e della settimana, accompagnando le esigenze delle persone e delle comunità.
Immaginiamo una scuola che il pomeriggio diventa centro civico o laboratorio creativo, una palestra scolastica che ospita corsi per adulti la sera, una biblioteca che nel fine settimana si trasforma in spazio coworking o sala eventi. O ancora un ufficio pubblico che, chiusa l’attività amministrativa, apre le sue sale a concerti, incontri o corsi di formazione. Questi luoghi si trasformano non con costosi interventi strutturali, ma grazie a pareti mobili, impianti modulari, arredi flessibili e una gestione intelligente degli accessi e delle prenotazioni.
Così facendo allunghi la vita utile di un edificio, riducendo i costi di manutenzione e ristrutturazione.
Qui la sicurezza non è affidata a cancelli e telecamere, ma alla presenza stessa delle persone che li abitano e li vivono.
Rigenerare significa proprio questo: restituire senso e bellezza a ciò che è stato abbandonato o sottoutilizzato. Ogni edificio vuoto, ogni area dismessa, ogni patrimonio storico dimenticato può tornare a vivere, generando valore economico, sociale e culturale.
La rigenerazione urbana non è solo una questione architettonica: è una scelta etica e sociale, che restituisce opportunità alle comunità e bellezza ai luoghi. Progetti come il quartiere Aurora a Torino o Base Milano lo dimostrano con forza: ex fabbriche e depositi industriali trasformati in poli culturali e sociali capaci di rigenerare interi quartieri, portando con sé nuova economia, sicurezza urbana e senso di appartenenza.
Anche il patrimonio storico, culturale e architettonico delle nostre città deve essere parte viva di questa trasformazione. Palazzi storici, ex conventi, cascine urbane possono essere rigenerati con tecnologie leggere e sostenibili, diventando coworking, laboratori artigianali, spazi culturali, aree verdi condivise, alloggi temporanei o studentati.
Così la storia non viene congelata in una cartolina museale, ma diventa terreno fertile per l’innovazione sociale e culturale.
Questa visione richiama profondamente il pensiero di Adriano Olivetti, che ci ha insegnato che impresa e architettura possono e devono essere motori culturali e sociali.
La città del futuro deve riscoprire questo spirito: non solo un aggregato di edifici e funzioni, ma una comunità viva e coesa. Luoghi dove si cresce come persone, come cittadini e come professionisti. Dove lo spazio non è solo un contenitore funzionale, ma un ambito di relazioni, formazione e crescita individuale.
Costruire questi luoghi significa anche contrastare il degrado e il senso di insicurezza: le persone che vivono e si riconoscono nei luoghi che abitano sono il primo presidio sociale, ben più efficace di qualsiasi telecamera o barriera.
In questa direzione, il modello dei “luoghi reversibili” diventa una proposta concreta e realizzabile. Ogni edificio può essere pensato per ospitare più funzioni: al mattino una scuola o un ufficio, al pomeriggio un centro culturale o sportivo, alla sera uno spazio civico o musicale, nel fine settimana un coworking o un mercato urbano.
La trasformazione avviene attraverso la progettazione flessibile di pareti mobili, impianti plug & play, arredi componibili, e grazie a una governance condivisa tra enti pubblici, imprese sociali, imprese edili innovative e cittadini attivi.
Le tecnologie smart per la gestione degli accessi, delle prenotazioni e della manutenzione completano il quadro rendendo tutto questo non solo possibile, ma sostenibile ed economicamente vantaggioso.
La realizzazione di questo modello non richiede utopie futuristiche, ma una volontà politica e sociale capace di superare la logica del “chiuso e statico” a favore di una città dinamica e flessibile, che cresce e si trasforma con chi la vive.
Serve un’alleanza tra progettisti visionari, imprese edili responsabili e comunità attive che sappiano co-gestire questi spazi, trasformando ogni edificio in un’occasione di incontro e ogni cantiere in un gesto di rigenerazione sociale.
In questa trasformazione, l’impresa edile non può più essere solo un esecutore di capitolati, ma un partner attivo della rigenerazione urbana. L’impresa edile del futuro è chiamata a integrare progettazione ed esecuzione, realizzando edifici reversibili, sostenibili e socialmente utili.
Costruire edifici multifunzionali e riqualificare aree degradate significa contribuire concretamente a rendere i quartieri più vivibili e sicuri, valorizzando non solo il capitale immobiliare, ma soprattutto il capitale sociale e culturale dei territori in cui opera.
Benessere urbano e sicurezza diffusa sono le conseguenze naturali di città ben progettate e vissute. Progettare il benessere significa garantire spazi accessibili, illuminati, inclusivi e confortevoli, capaci di accogliere persone diverse e attività diverse.
È dimostrato che quartieri ben progettati, con una forte presenza di attività e relazioni sociali, generano sicurezza naturale, senza bisogno di barriere fisiche o controllo forzato.
La presenza umana spontanea diventa il miglior deterrente per il degrado e l’insicurezza.
La sicurezza urbana è un beneficio collaterale e naturale di spazi ben progettati e vissuti. Non basta edificare volumi: serve costruire senso e relazioni, trasformare ogni edificio in un luogo vivo e ogni quartiere in un ecosistema che respira e cresce insieme alle persone che lo abitano.
Ogni progetto e ogni cantiere può essere un gesto etico: un’impronta che lascia traccia nel tempo, che costruisce benessere, relazioni e sicurezza diffusa.
Così immagino le città che respirano: spazi reversibili e multifunzionali, capaci di accogliere e trasformare, radicati nella storia ma aperti all’innovazione, dove ogni persona possa crescere e costruire il proprio futuro insieme agli altri. Città dove l’edilizia torna a essere, come nelle migliori esperienze del nostro passato, non solo un’attività tecnica ma un atto culturale e civile.