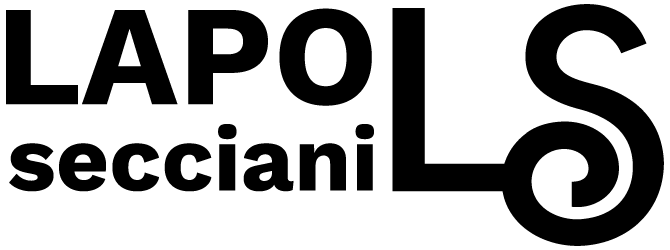Entro il 2050, il 41% delle famiglie italiane sarà composto da una sola persona.
Non è una suggestione narrativa: è la fotografia cruda scattata dall’ISTAT. Mentre la popolazione complessiva diminuirà di oltre 4 milioni, aumenteranno nuclei unipersonali, fragilità, solitudini.
Ma il vero allarme non è solo demografico. È esistenziale.
È il progressivo svuotamento relazionale che sta ridisegnando il nostro abitare.
Per troppo tempo abbiamo costruito città e case come contenitori di individui, anziché come infrastrutture relazionali per comunità. Abbiamo normalizzato il distacco, l’isolamento, l’individualismo come elementi strutturali dell’abitare.
Il risultato?
Mura che separano, ascensori che non uniscono, quartieri che non parlano.
Nel cuore di questa trasformazione si combatte una lotta di specie.
Da un lato l’Homo ego-centrico: proprietario geloso dei suoi spazi, isolato, consumatore passivo di città e servizi.
Dall’altro l’Homo ECO-centrico: abitante consapevole, che riconosce il legame tra benessere personale, salute collettiva e qualità dello spazio vissuto.
È tra queste due visioni che si gioca il futuro delle nostre città, delle nostre imprese e delle nostre relazioni.
Nel tempo delle solitudini, il tema dell’abitare si trasforma in emergenza sociale e progettuale.
Non è solo questione di edilizia: è questione di senso.
Chi vogliamo diventare? E quale habitat vogliamo costruire per sostenere quella trasformazione?
Oltre la casa: un ecosistema a misura di persona
Il co-housing – nella sua declinazione evoluta – è una risposta concreta, profonda, già possibile. Non si tratta di vivere insieme per risparmiare, ma di costruire un habitat condiviso, flessibile, solidale, dove spazi privati e comuni coesistono in equilibrio.
Dove vivere non è solo abitare, ma coltivare legami.
Nel co-housing ogni elemento è progettato per favorire relazioni: cucine comuni, spazi per il lavoro, orti urbani, sale lettura, aree gioco. Ma soprattutto: una governance partecipativa, che restituisce ai cittadini il potere di decidere insieme.
È la trasformazione del condominio da “scatola” a comunità attiva, capace di rispondere ai bisogni dei singoli attraverso la forza del collettivo.
Non si tratta di utopie nordiche: è una rivoluzione realizzabile, applicabile anche nei centri storici, nei borghi, nei nuovi insediamenti.
La mia convinzione – di cui più volte ho scritto – è chiara: la casa del futuro è modulare, reversibile, resiliente, pensata sia per adattarsi alle fasi della vita, alle relazioni che cambiano, agli stili di vita emergenti, che per recuperare quel senso umano e sociale che i ritmi frenetici imposti da questa società odierna hanno eroso.
È un sistema costruito attorno alla persona, ma inserito in un ecosistema umano, ambientale e tecnologico.
La città che respira, il quartiere che cura
Tutto questo non può avvenire se l’urbanistica resta vincolata a schemi statici, verticali, impermeabili al cambiamento.
Serve un modello vivo di sviluppo urbano, capace di ibridare funzioni, tempi, esperienze.
Servono città che respirano, che mettono in relazione residenza, lavoro, cultura, natura. Quartieri porosi, accessibili, belli. Dove il verde non è elemento decorativo, ma spazio sociale e sanitario, infrastruttura ecologica e luogo educativo.
E serve una nuova governance urbana, che superi la dicotomia tra pubblico e privato, aprendosi a formule cooperative, ibride, benefit.
L’abitare del futuro sarà sostenibile se saprà essere partecipato, generativo e rigenerativo. Se saprà rigenerare anche il senso del vivere insieme, non solo le facciate.
Un’altra idea di casa, di impresa, di specie
Rigenerare l’abitare non è solo un progetto tecnico o sociale: è una sfida culturale profonda.
Una scelta di campo. In un tempo che ha esasperato l’individualismo, tornare a progettare forme dell’abitare che coltivano la prossimità è un atto radicale.
Vuol dire restituire alla casa il suo potenziale trasformativo: non come status, ma come spazio di relazione.
Vuol dire smettere di pensare alla città come a un insieme di funzioni da gestire, e iniziare a viverla come una comunità da costruire.
Vuol dire concepire l’impresa non come entità estrattiva, ma come organismo vivo che contribuisce all’equilibrio tra persone e ambiente.
Vuol dire passare – giorno dopo giorno – dalla specie che consuma alla specie che cura.
Non basta costruire case.
Dobbiamo costruire possibilità.