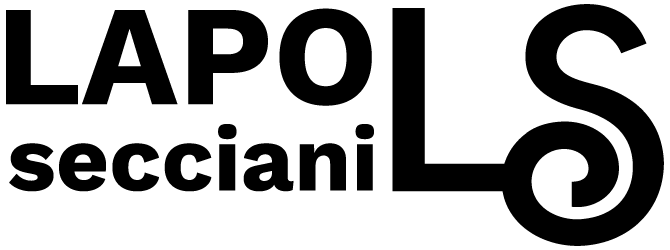La fabbrica nella comunità
Lo sviluppo economico è reale quando guarda all’impatto sociale.
L’azienda intesa come luogo dove le persone trovano opportunità di crescita personale, professionale e sociale nate dalle relazioni e opportunità che il territorio offre.
Citando le parole di Olivetti, il territorio diventa una “metafabbrica” capace di creare valore in un’economia dove risorse, opportunità e conoscenze sono condivise per creare reti e relazioni -professionali e personali- solide.
L’impresa deve essere sviluppata come luogo dove le persone possano valorizzare il proprio io, grazie ai loro talenti e le loro unicità.
Oggi più che mai modello capitalistico basato sul paradigma “mors tua vita mea” non funziona più. Serve un modello dove il mio guadagno e il mio benessere sono frutto di un lavoro che permette al prossimo di vivere e guadagnare dignitosamente.
Ecco quindi che, per essere solido e soprattutto per avere orizzonti concreti nel medio-lungo termine, lo sviluppo economico deve far coesistere la propria sostenibilità economica con la capacità di generare impatti positivi, non solo in termini ambientali, ma anche e soprattutto sociali.
È necessario riscoprire il rapporto tra la produzione e il territorio, capace di generare valore anche identitario.
Se guardiamo a come facevamo impresa negli anni ’60, nel periodo del boom economico, ritroveremo quel valore non solo economico, ma anche sociale e identitario.
Un’impresa in cui le persone trovano le proprie realizzazioni, personali e professionali, è un’impresa che nasce dalla visione e dal sogno di una persona (o di un gruppo) e che è ossessionata dal veder realizzata quella visione e quel sogno.
Questo significa che l’impresa non si sviluppa grazie a un capitale che aspira ad accrescere, ma invece da un organismo che affonda la sua idea nelle relazioni sociali e nelle opportunità offerte dal territorio.
Nell’impresa non viene investito semplicemente il denaro, ma la reputazione stessa dell’imprenditore, le relazioni, che si è costruito nel tempo, con la comunità e soprattutto con le persone che la compongono.
È questo il suo capitale.
A livello economico, si parla di passaggio dall’economia del singolo alla società delle relazioni.
È questo uno scenario, che, come detto, abbiamo vissuto in passato, nel quale non c’è più – per forza – il dominio dell’economia lineare; il modello alternativo è dunque l’economia condivisa.
È un cambiamento che sta portando alla costruzione di una società -e di un mondo- sempre meno ego-centrico e sempre più ECO-centrico.
Un cambiamento evidenziato dalla crisi economica che abbiamo e stiamo affrontando. In questi anni abbiamo provato -senza riuscirci- a gestire una crisi di sistema puntando principalmente -o esclusivamente- su strumenti tecnologici e finanziari.
I risultati ottenuti ci indicano che la tecnologia e la finanza non sono sufficienti a gestire quello che è un vero cambio di epoca (e non epoca di cambiamenti).
Per governare questo cambio di epoca e non subire gli effetti di una crisi che, evidentemente, non è solo economica ma anche -e soprattutto- sociale e valoriale, occorre riscoprire il vero ruolo del fare impresa e della fabbrica.
La fabbrica e i territori
La storia dello sviluppo della fabbrica è da sempre associabile all’intero paese e al territorio circostante. La storia del paese era quindi inevitabilmente legato allo sviluppo dell’impresa, delle persone, dei luoghi e relazioni che si creavano.
Questo è ciò che succedeva negli ’60 e questo è ciò che ha permesso all’Italia di vivere il proprio boom economico, affermando il marchio del Made in Italy come eccellenza invidiata nel mondo.
Questo è quella visione che ha reso un “uomo del futuro” Adriano Olivetti.
È riscoprendo le nostre origini che le aziende trovano la propria e una nuova via evolutiva: concreta, reale e vincente.
Il territorio diventa quindi una “metafabbrica”, perché non usano solo le risorse del luogo (sociali, economiche o ambientali), ma diventano veri elementi strutturanti della geografia dei luoghi, delle persone e delle comunità.
Generando non solo valore economico, ma anche e soprattutto sociale ed ambientale.
L’Italia di inizio Novecento, come già sottolineato, ben si conciliava con questa visione di “metafabbrica”, poiché vi era un’organizzazione del territorio nel quale c’era un rapporto indissolubile tra luogo produttivo e luogo abitato, tra tempi della produzione e tempi di riposo, tra luoghi di lavoro e luoghi di cultura.
Tutto questo Olivetti lo teorizzava nella sua idea di comunità e di azienda, che ha visto la luce ed è diventata reale nelle terre del Canavese sviluppandosi intorno a una fabbrica che riconosceva la centralità dell’uomo.
Dal dopoguerra si è iniziato a pensare a un modello urbanistico dove i luoghi dell’abitare sono separati da quelli della produzione e dagli altri per il tempo libero. Un modello adottato sia per i piccoli centri che per le grandi metropoli.
Il grande limite di questa visione urbanistica è l’essersi concentrati solo sul valore economico dei luoghi e sulla possibilità di un loro sfruttamento.
Una logica che ha resistito fino alla recente crisi, che ne ha messo in evidenza i tutti i limiti di un modello di territorio diviso per funzionalità. L’essere umano ha bisogno di socialità, di sviluppare e valorizzare i propri talenti condividendoli, lasciandosi contaminare dal prossimo in un continuo scambio di esperienze, di opportunità, di vissuto.
Gli spazi diventano luoghi quando questi sono vissuti e utilizzati, da persone che, da quei luoghi e grazie a quei luoghi, riescono a trovare la loro dimensione umana e professionale.
Non più economia, ma socialità circolare.
Adriano Olivetti con la sua idea di fabbrica come territorio sociale e luogo di comunità ci lascia molto più che una ‘lezione’, nella sua azione e nel suo pensiero concreto troviamo una mappa capace di guidarci nell’unico futuro possibile.
“La fabbrica è luogo dove c’è giustizia e domina il progresso, dove si fa luce la bellezza, e l’amore, la carità e la tolleranza sono nomi e voci non prive di senso”, diceva Olivetti, una visione antitetica, rispetto al pensiero comune, di fabbrica che è intesa come luogo di inclusione e capace di interpretare il ruolo di equilibratrice nello sviluppo economico e sociale.
La “metafabbrica” altro non è che l’attualizzazione del pensiero e dell’azione ‘rivoluzionaria’ di Olivetti che vede la fabbrica come un luogo che vive il suo territorio, dal quale trae le risorse primarie (il lavoro) per produrre valore. Un luogo che restituisce non solo posti di lavoro, ma benessere, economico e sociale, nuove relazioni e un nuovo modo di integrazione tra luoghi e persone.
Fare impresa oggi significa chiedersi che cosa chiede e offre il territorio e soprattutto comprendere quale ruolo sociale può e deve rivestire la fabbrica (azienda) per costruire valore sociale nella sua area geografica, nella sua comunità.
Il valore è sempre più LA parola chiave, perché è su esso che si fonda il concetto di reputazione e di appartenenza: percependo valore poniamo attenzione, ci mettiamo in ascolto e in relazione, perché comprendiamo che quel valore può entrare nella nostra vita di lavoratori e imprenditori, migliorando persone e luoghi.
Solo così possiamo parlare di circolarità, perché, non è l’economia che deve essere circolare, ma il territorio e la comunità che non possono più essere pensati come corpi separati.
Non è più rilevante che cosa produco, ma diventa indispensabile il come, il dove, ma soprattutto con chi e per chi lo faccio, quali relazioni instauro.
Questa l’unica strada per costruire un nuovo modello, di società e di impresa, che sia sempre più ECO-centrico e sempre meno ego-centrico, dove il guadagno e il benessere di uno sia il risultato di un lavoro che permette al prossimo di lavorare e vivere in modo dignitoso.