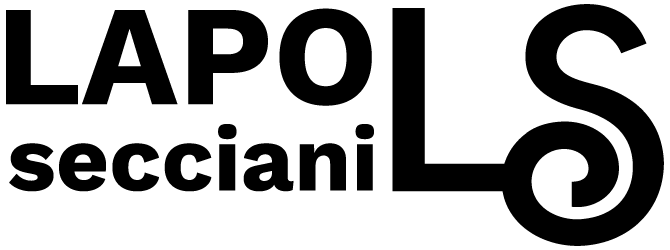Negli ultimi mesi si è tornato a parlare del livello di preparazione e della qualità della leadership nelle imprese italiane.
Prima, a marzo, un’indagine riportata su “Il Sole 24 Ore” raccontava di manager spesso insicuri, che loro stessi si giudicano poco pronti a ricoprire il proprio ruolo. Poi, a luglio, sempre su “Il Sole 24 Ore”, la ricerca condotta da Hays ha ribaltato il punto di vista: stavolta a parlare sono stati i lavoratori.
Il verdetto è stato impietoso: per metà degli intervistati, i manager non arrivano alla sufficienza.
Due punti di vista, una stessa fragilità: il management italiano fatica a stare al passo con i tempi.
Attenzione, però: leggere questi dati solo come un j’accuse verso manager e dirigenti d’impresa rischia di essere una scorciatoia comoda.
La realtà è più complessa e richiede uno sguardo più profondo. Richiede, soprattutto, il coraggio di parlare di corresponsabilità.
Il manager non è un supereroe (ma nemmeno un capro espiatorio)
Che molti manager e dirigenti italiani siano impreparati, autoreferenziali, più capetti che leader, non è una novità.
Viviamo in un Paese che per decenni ha confuso il comando con il controllo, la leadership con il potere gerarchico, l’autorità con il ruolo.
Una cultura che ha prodotto generazioni di dirigenti poco formati alla gestione delle persone e molto formati (male) alla gestione dei numeri.
È altrettanto vero che, troppo spesso, scarichiamo ogni responsabilità sui vertici, dimenticando che ogni organizzazione è un ecosistema, non un monolite.
Un manager può (e deve) indicare la direzione, ma se il team non segue con consapevolezza, preparazione e responsabilità, il cambiamento non avverrà.
Così come – viceversa – un team eccellente può essere bloccato da una leadership inadeguata.
Il punto vero è che il successo (o il fallimento) di un’impresa si costruisce insieme, nella relazione tra chi guida e chi segue, tra chi progetta e chi esegue, tra chi decide e chi realizza.
Un mercato del lavoro spaccato (e ipertutelato)
Non possiamo nemmeno ignorare un’altra dinamica poco discussa: viviamo in un mercato del lavoro dove, in molti contesti, il lavoratore dipendente è ipertutelato, anche quando le sue performance non sono all’altezza.
Al contrario, i manager (soprattutto quelli di medio livello) sono spesso i primi a pagare il prezzo degli insuccessi aziendali, soggetti a valutazioni stringenti, target e pressione continua.
Una disparità che non dovrebbe alimentare guerre tra categorie, ma farci riflettere su quanto il nostro sistema sia stato costruito più sulla tutela statica dei ruoli che sulla crescita dinamica delle persone.
Abbiamo lasciato che il mercato del lavoro diventasse il campo di battaglia di una narrazione divisiva: da una parte i “padroni” o i manager cattivi, dall’altra i lavoratori vittime da proteggere.
Invece di alimentare una cultura della corresponsabilità, del talento e della partecipazione, abbiamo scavato un solco che mira solo a evidenziare colpe, deresponsabilizzare e allontanare le parti di uno stesso eco-sistema.
Ma un’impresa – come una comunità – non cresce nella divisione: cresce quando ognuno riconosce il proprio ruolo e la propria responsabilità nel creare valore condiviso.
L’Italia gerontocratica e il coraggio della modernità
L’Italia – ad oggi – è ancora prigioniera di una cultura gerontocratica e paternalista. Una situazione che, in questo contesto, non può e non deve essere ignorata.
In molte aziende, la leadership è esercitata da chi “c’era prima”, indipendentemente dalle competenze, e la crescita dei collaboratori è vista come una minaccia più che un’opportunità.
Ma il futuro non aspetta.
I leader devono aggiornarsi, aprirsi, imparare competenze e cose nuove.
I collaboratori devono smettere di aspettare che tutto cambi “da solo”, che sia sempre qualcun altro a dargli motivazioni, strumenti e direzioni.
Lo hanno insegnato bene Adriano Olivetti e Sergio Marchionne, due figure diversissime ma accomunate da un’idea chiara: il successo non è mai solo merito (o colpa) di un singolo. È una costruzione collettiva.
Un’impresa vive quando le persone, tutte, si sentono responsabili del proprio pezzo di futuro.
Uscire dalla comfort zone del vittimismo
Dire che i manager e i dirigenti delle imprese italiane sono incapaci è facile.
È una narrazione che ci assolve, che ci tranquillizza. “Se le cose non vanno, è colpa loro”.
Ma questa narrazione non cambia nulla.
Servono manager e dirigenti d’impresa più preparati, senza dubbio. Ma servono anche collaboratori più adulti, più formati, più partecipi.
Serve un nuovo patto culturale nelle aziende italiane, soprattutto nelle PMI, che ancora oggi faticano ad uscire dalla logica padronale o familistica
Un patto fatto di ascolto, formazione continua, obiettivi chiari e condivisi.
Dove il capo non è un despota, ma nemmeno un parafulmine buono per ogni stagione.
Dall’ego-centrismo all’ECO-centrismo
Alla fine, tutto questo richiama la grande sfida del nostro tempo: la battaglia di specie tra l’homo ego-centrico, che vede il mondo solo in funzione dei propri diritti e del proprio ruolo, e l’homo ECO-centrico, che riconosce di far parte di un tutto più grande e – consapevole dell’importanza dell’identità personale di ogni individuo – è convinto che il noi sia più importante dell’io.
Le aziende, come la società, sono ecosistemi viventi.
E in un ecosistema ogni elemento conta, ma nessuno può bastare a se stesso.
È il passaggio dall’apparire e mostrare – che porta conflitti, divisioni e inutili recite – all’essere e fare, che costruisce valore reale e relazioni vere.
Manifesto per una nuova impresa italiana
Smettiamola di dividerci tra capi incapaci e lavoratori vittime.
Iniziamo a costruire aziende dove ognuno, dal primo all’ultimo, è chiamato a dare il meglio.
Dove chi guida studia, ascolta, si mette in discussione.
E dove chi segue propone, partecipa, si assume responsabilità.
Le imprese italiane hanno bisogno di questo patto nuovo.
Un patto fatto di competenza, coraggio, umiltà e fiducia reciproca.
Chi è pronto a farne parte?
Chi è pronto a chiedersi non solo “cosa non va negli altri”, ma “cosa posso fare io per migliorare le cose”? Perché il futuro del lavoro – e del Paese – inizia esattamente da questa domanda.