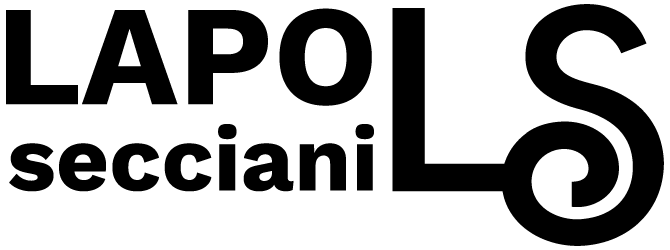Quando parliamo di giovani e lavoro, rischiamo di cadere in due trappole. La prima è l’etichetta facile: i giovani sarebbero fragili, sfuggenti, incapaci di sacrificarsi.
La seconda, speculare, è l’idolo generazionale: i giovani sarebbero migliori di noi, portatori di senso e futuro.
La verità, come spesso accade, sta altrove: nelle persone, nei valori, nelle scelte.
Il lavoro, oggi, è il terreno di una battaglia silenziosa fra due modi opposti di stare al mondo: da una parte l’homo ego-centrico, che cerca il proprio tornaconto personale; dall’altra l’homo ECO-centrico, che vede nel lavoro un’opportunità di costruzione collettiva e cura reciproca.
Una sfida che attraversa ogni generazione e ogni ruolo aziendale, ma che oggi si manifesta con particolare evidenza nel rapporto che i giovani hanno con il lavoro.
Molti di loro cercano nel lavoro non solo uno stipendio, ma un senso. Vogliono sentirsi parte di qualcosa di più grande, ma troppo spesso incontrano aziende che parlano ancora il linguaggio sterile del controllo e della produttività fine a sé stessa. Così oscillano, tra il bisogno di stabilità e la voglia di autonomia, tra il sogno di costruire la propria impresa e la ricerca di contesti capaci di accoglierli e farli crescere.
Nessuna strada è giusta o sbagliata in assoluto: importa come viene percorsa.
E questo ci riporta alla domanda centrale: per chi e per cosa lavoriamo?
Le imprese capaci di attrarre i giovani migliori –e con migliori non intendo solo i più preparati tecnicamente, ma i più vivi interiormente– non sono necessariamente quelle che offrono stipendi più alti.
Sono quelle che sanno proporre un percorso, un senso, una comunità.
Quelle che sfidano e accompagnano, che chiedono molto ma restituiscono altrettanto, che sanno riconoscere il valore del singolo senza separarlo dal bene comune.
Qui si intrecciano, in modo più profondo di quanto sembri, le visioni di due figure spesso considerate distanti: Adriano Olivetti e Sergio Marchionne.
Olivetti ci ricorda che l’impresa è prima di tutto una comunità viva, un luogo in cui il lavoro e la cultura, il profitto e il benessere collettivo si tengono insieme in un equilibrio dinamico. Non un’azienda chiusa su sé stessa, ma un pezzo di società responsabile verso i territori e le persone che la abitano.
Marchionne, dal canto suo, ci ammonisce su un punto altrettanto cruciale: nulla viene regalato, tutto ciò che vale si costruisce con determinazione, disciplina e fatica. La dignità del lavoro non si conquista con le dichiarazioni di principio, ma nella concretezza delle sfide quotidiane.
Queste due visioni, apparentemente distanti, in realtà si completano: senza il rigore e il merito evocati da Marchionne, la comunità olivettiana rischierebbe di trasformarsi in un’utopia fragile, incapace di reggere alla prova del tempo e del mercato. Senza la visione comunitaria di Olivetti, il rigore di Marchionne rischierebbe di diventare freddo efficientismo, privo di anima e di senso collettivo.
L’impresa che serve ai giovani oggi –e alla società intera– è quella capace di tenere insieme queste due anime: quella che costruisce comunità e quella che esige impegno. Un’impresa umana e severa, accogliente e sfidante, capace di chiedere molto e al tempo stesso di dare molto, non solo in termini materiali ma, anche e soprattutto, in termini di crescita personale e collettiva.
Accanto alle loro luci, i giovani portano fragilità reali, che non possiamo né ignorare, né sottovalutare.
Studi internazionali mostrano come nel passaggio dalla scuola al lavoro emergano significative carenze nelle soft skills, competenze sempre più determinanti nel mondo del lavoro attuale: resistenza allo stress, capacità di lavorare in gruppo, pensiero critico, gestione dei conflitti, comunicazione efficace.
La pandemia, l’iperconnessione e la didattica a distanza hanno accentuato questo squilibrio: il digitale è stato potenziato, ma a scapito dell’empatia, dell’ascolto reciproco, del confronto reale e faticoso che educa alla collaborazione autentica.
Queste carenze non sono colpa dei giovani.
Sono il risultato di un sistema educativo e sociale che ha privilegiato la trasmissione di contenuti tecnici, trascurando la formazione del carattere e delle relazioni umane. Eppure, in un mondo dove l’AI e l’automazione renderanno obsolete molte competenze tecniche, saranno proprio le capacità di negoziare, collaborare e gestire le relazioni a fare la differenza tra chi sarà sostituibile e chi resterà necessario.
Eppure, accanto a queste lacune – come già detto – ci sono luci potenti: capacità di apprendimento rapido, una visione più etica e inclusiva, creatività fluida e sete autentica di futuro.
Sta a noi – manager, imprese, educatori – non lasciarle spegnere.
Non proteggendoli troppo, ma nemmeno abbandonandoli a sé stessi.
Allenandoli, sfidandoli, accompagnandoli lungo un percorso di crescita reale. Servono leader-allenatori, aziende che siano spazi di crescita relazionale, e processi di selezione più profondi, capaci di scegliere non solo chi sa già fare, ma chi vuole mettersi in gioco, crescere e lavorare con passione e responsabilità.
La vera partita non è tra tipi di contratto o generazioni, ma tra due concezioni del lavoro: chi lo vive per il proprio ego e chi lo vive per generare impatto positivo.
Non tutti i giovani incarnano la seconda visione, né tutti gli adulti restano prigionieri della prima. Ma questa è la sfida che conta.
Io, ogni giorno, provo a farlo nel mio piccolo: seguo le orme di Olivetti e Marchionne –comunità e merito– e cerco di trasmetterlo ai giovani che incontro. Non per convincerli, ma per camminare insieme qualche tratto di strada.
Perché il futuro non ci è dovuto. Il futuro si costruisce, ogni giorno, insieme.