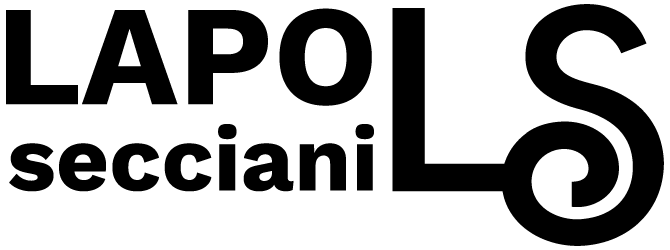Viviamo un tempo in cui la solitudine delle piccole imprese rischia di diventare una condanna. A fronte di un mercato sempre più complesso e competitivo, molte realtà si ritrovano a gestire da sole problemi sistemici: scarsità di risorse, mancanza di competenze trasversali, difficoltà a intercettare grandi commesse o a scalare in qualità. Quella dimensione che un tempo era sinonimo di agilità e resilienza oggi rischia di trasformarsi in un limite strutturale.
Eppure, la risposta non può essere la perdita di identità o l’omologazione dentro modelli impersonali. La vera sfida è un’altra: fare rete senza perdere sé stessi.
Negli ultimi anni, una certa narrazione politica ed economica ha finito per dipingere il modello della piccola impresa come il problema del sistema Paese. Troppo piccole, troppo fragili, troppo radicate nel territorio per essere moderne. Eppure, sono proprio loro a sostenere lo Stato sociale, sia in termini di contribuzione fiscale che di valore aggiunto generato in rapporto al numero di addetti. La piccola impresa non è un’anomalia da correggere, è la colonna vertebrale su cui poggia la tenuta di intere comunità.
È facile, troppo facile, scadere nella retorica della collaborazione. Ma la verità è che molte piccole imprese non si alleano non per mancanza di volontà, ma per paura. Paura di perdere il controllo, di snaturare la propria visione, di diventare pedine nel gioco di qualcun altro. Una paura spesso alimentata da un modello d’impresa, tipicamente italiano, fortemente legato alla gestione familiare e generazionale, dove l’età media dei capitani d’impresa è elevata, e la cultura del controllo – quando non c’è iper-ricchezza – genera diffidenza verso tutto ciò che non è interno.
La grande industria riesce in parte a mitigare questo limite. Ma nella piccola impresa, che non può permettersi strutture manageriali complesse, la diffidenza diventa spesso zavorra. È il frutto di un’educazione scolastica e familiare che non valorizza la condivisione, che non allena alla collaborazione, ma al raggiungimento individuale di un risultato. Alla conservazione di una posizione, più che alla costruzione di un cammino collettivo.
Eppure il bisogno è urgente. È il tempo di un cambio di paradigma. Serve un nuovo ecosistema fatto di reti professionali tra imprese che rispettino le identità e, proprio grazie a questa identità, sappiano verticalizzarsi nella propria eccellenza. Un sistema in cui le differenze siano una ricchezza, una contaminazione virtuosa, una leva di sviluppo. Dove le best practice diventino patrimonio comune, dove il personale possa circolare in modo intelligente e fiducioso, dove sia possibile accedere a competenze manageriali condivise e modulari, senza snaturare l’organizzazione.
Un ecosistema, nel senso più profondo del termine.
Un insieme organico, fatto di organismi diversi – le imprese – che interagiscono tra loro e con l’ambiente circostante.
Un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico, dove oggi tira uno, domani un altro. Dove oggi un’impresa coglie un vantaggio, e domani lo offre a qualcun altro.
Un meccanismo di sussidiarietà attiva, dove il benessere di uno alimenta la tenuta del tutto.
Questa visione ha radici forti.
È la visione di Adriano Olivetti, che ha dimostrato come impresa, cultura e comunità possano convivere in un unico sistema armonico, capace di generare valore oltre il profitto. Olivetti ci insegna che l’impresa è un organismo vivo, che respira nel territorio, nelle persone, nella cultura materiale e immateriale che produce.
Ed è anche il rigore di Sergio Marchionne, che ci ricorda l’importanza della responsabilità, della fatica, della chiarezza nei ruoli e nella direzione. Il coraggio di fare scelte impopolari, di cambiare ciò che va cambiato. Il valore del dovere, prima ancora del diritto.
Immagino allora una piazza rinascimentale 5.0.
Uno spazio aperto e dinamico, dove ogni impresa porta il proprio talento, il proprio stile, la propria etica. Una piazza viva, non un centro commerciale del lavoro. Un luogo dove le persone si incontrano, si osservano, si contaminano.
Come accadeva nel Rinascimento, quando maestri artigiani lavoravano uno accanto all’altro, lasciandosi influenzare, imparando l’uno dall’altro, mentre gli allievi affinavano le proprie abilità e la comunità viveva la propria dimensione pubblica.
Creatività, ambizione, coraggio e innovazione nascevano proprio lì: nella piazza.
Rigidità nei valori. Flessibilità nei processi.
Non è la strategia a definire un’impresa.
Non è neanche solo il marchio, il brand.
Sono i valori.
Il perché si fa una cosa, e il come la si fa.
Condividere idee, personale, filiere o strategie con altri non significa rinunciare, ma espandere ciò che si è.
Mettere i propri valori in circolo, farli conoscere, renderli visibili.
Una rete ben costruita non disperde le identità, le rafforza.
Il problema non è la dimensione.
Piccolo non è male.
Piccolo è bello, se c’è apertura.
Perché quando si rema dalla stessa parte, quando si gioca per un obiettivo comune che non nutre solo l’io ma valorizza il noi, allora non si è mai soli nelle difficoltà.
Il successo non è più individuale, ma collettivo.
Si gioca e si vince come una squadra, moltiplicando forza, esperienza, conoscenze e valore.
“Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo, o saremo annientati individualmente. […] Allora, che cosa volete fare?”
Any given sunday – coach Tony D’Amato
Ce lo dice il Coach Tony D’Amato in Ogni maledetta domenica.