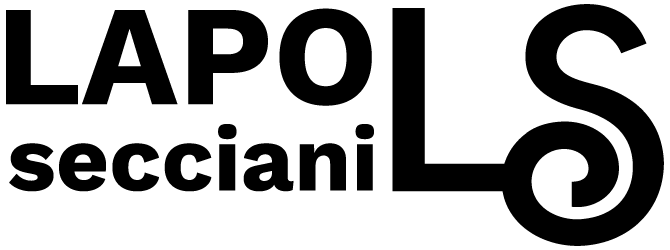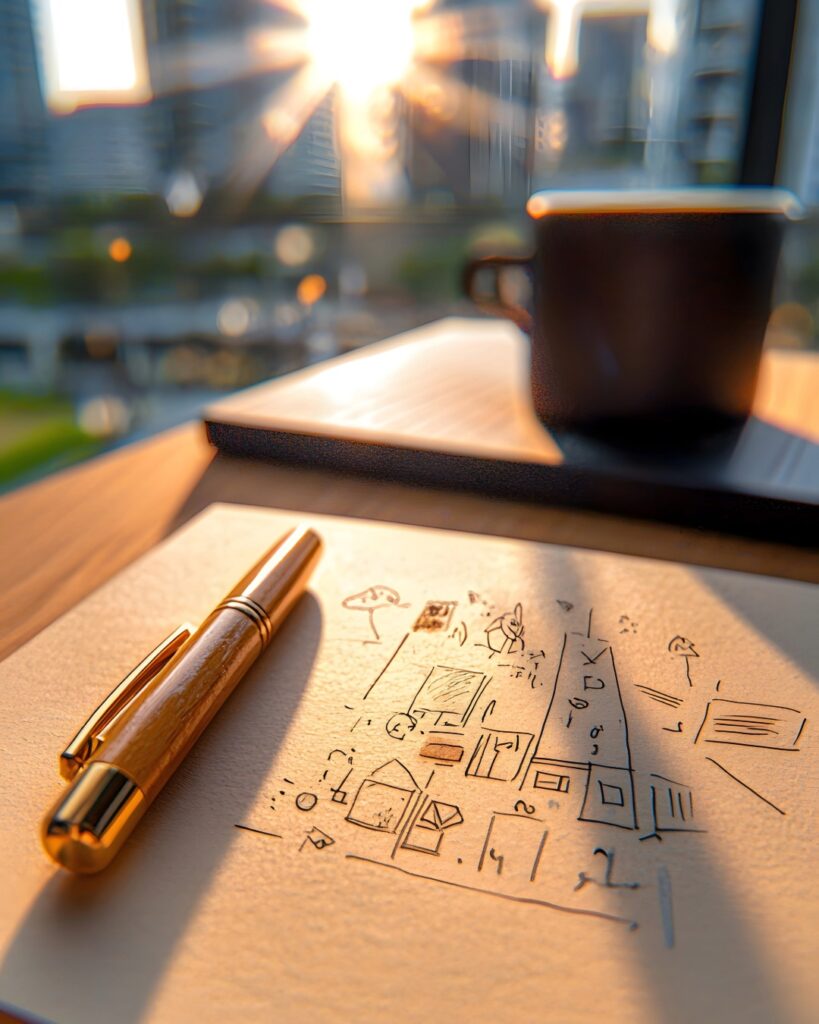
Ci sono momenti, nella vita di un’impresa, in cui bisogna scegliere se restare ancorati a ciò che si conosce o se rischiare di mettere piede su terreni ancora inesplorati.
Il vero salto avviene quando radici e orizzonti smettono di essere due concetti separati.
Le radici sono il territorio: conoscerne i ritmi, la geografia industriale, le persone che fanno accadere le cose. Sono i cantieri che vedi crescere ogni giorno, le relazioni costruite a colpi di fiducia, la capacità di muoversi tra normative e abitudini locali come chi sa leggere un paesaggio senza bisogno di mappe.
Gli orizzonti sono un’altra cosa: sono le linee lunghe del mercato, i flussi che arrivano dai grandi fondi, le traiettorie urbane che cambiano le città. Sono le relazioni con chi immagina progetti destinati a diventare punti di riferimento, con chi dialoga alla pari con investitori internazionali e governa processi complessi.
Per troppo tempo, in edilizia, queste due dimensioni sono rimaste lontane.
Oggi – in un contesto che richiede velocità decisionale, integrazione di competenze e sostenibilità misurabile – il valore nasce quando si riesce a metterle in relazione, creando contaminazione e condivisione autentica.
Non parlo di fusioni o acquisizioni, ma di ponti: infrastrutture di collaborazione dove il radicamento territoriale diventa la naturale estensione di chi porta visione e network, e dove il concept progettuale trova nella concretezza operativa un alleato e non un ostacolo.
La testa di ponte territoriale
Un’impresa radicata in Emilia-Romagna può fare molto più che “presidiare” un’area geografica. Può diventare testa di ponte: tradurre la visione di un progetto in scelte operative coerenti con la cultura costruttiva locale, senza snaturarne l’identità.
Può anticipare problemi prima che diventino varianti, garantire tempi certi, selezionare fornitori con esperienza reale, armonizzare la logistica con il contesto.
Così, ogni cantiere diventa la continuazione naturale di un concept, e non il luogo in cui quel concept si perde tra compromessi e adattamenti frettolosi.
Dare profondità con la parte “construction”
Molti grandi progetti si fermano a metà del guado: hanno un disegno straordinario ma non una regia di cantiere capace di sostenerlo.
Questa discrepanza genera disallineamenti, aumento dei tempi e dei costi.
Qui, la capacità di contaminazione e condivisione – vera – tra l’area progettazione e l’area construction fa la differenza:
- tradurre i dettagli di progetto in sequenze operative ottimizzate;
- scegliere tecniche e materiali che garantiscano adattabilità e manutenzione semplice;
- preservare la qualità architettonica anche quando le condizioni cambiano.
Non si tratta di “correggere” la visione, ma di darle spessore.
Di far sì che l’edificio, oltre a essere bello, sia anche funzionale, trasformabile e durevole.
Portare opportunità, non solo eseguire
Molti studi di progettazione non sviluppano direttamente business immobiliari: rispondono a una domanda espressa, non creano la domanda.
Eppure, nel mercato attuale, esiste spazio per chi sa intercettare canali e capitali e proporre operazioni complete: concept + business plan + execution.
La capacità di disegnare il futuro, di vedere strade non ancora tracciate, si trasforma in opportunità reali capaci di generare valore economico, sociale e ambientale per tutti gli stakeholder.
Significa dialogare con i fondi non solo per presentare un progetto, ma per proporre un’operazione già strutturata, con rischi calcolati, ritorni stimati e un modello di gestione integrato.
Chi riesce a portare progetti bancabili e al tempo stesso realizzabili sul territorio diventa un partner strategico, non un semplice fornitore.
Formare la nuova generazione di project manager
Il ricambio generazionale non è un tema astratto: è un’urgenza, soprattutto quando si parla del cantiere.
Ci sono competenze che rischiano di scomparire e che vanno trasmesse prima che sia troppo tardi.
Serve un’Academy capace di crescere figure che conoscano sia il linguaggio della creatività progettuale sia quello della gestione di cantiere. Professionisti in grado di:
- coordinare fornitori e subappalti;
- monitorare costi e tempi in tempo reale;
- leggere i disegni non solo per capirli, ma per anticipare le criticità;
- proporre varianti intelligenti che mantengano intatto il valore del concept.
Un futuro project manager non può più essere un “traduttore” passivo tra ufficio tecnico e cantiere: deve essere un orchestratore.
Un modello di sostenibilità integrato
La sostenibilità vera non è un’etichetta, ma una metrica condivisa tra progettazione e realizzazione.
Penso a un modello operativo che includa:
- indicatori ambientali, sociali ed economici già in fase di concept;
- sistemi di raccolta dati in cantiere (consumi, rifiuti, sicurezza, filiera);
- rendicontazione semplice e trasparente per investitori e stakeholder.
Rendersi misurabili in ogni area aziendale significa individuare parametri oggettivi capaci di aiutare l’impresa a migliorarsi in performance, redditività e qualità del lavoro.
Così, la sostenibilità smette di essere un obbligo formale e diventa una leva competitiva concreta.
Una piazza per le imprese benefit
Vedo l’opportunità di creare un tavolo di lavoro permanente composto da imprese benefit: un luogo – fisico e relazionale – in cui eccellenze locali si incontrano per sviluppare progetti ad alto impatto per il territorio.
Un salotto in cui ogni azienda porta il proprio know-how ma lavora su un modello di sinergia strutturata, pronto a rispondere a bandi, fondi e iniziative private con una proposta integrata e credibile.
In un settore che ancora procede per compartimenti stagni, il futuro apparterrà a chi saprà costruire ponti: tra competenze e mercati, tra creatività e tecnica, tra il territorio e il mondo.
Se le radici sono solide e l’orizzonte è ampio, sopra quei ponti passeranno non solo progetti, ma intere visioni di città e di futuro.
E io credo che sia esattamente lì – nel punto in cui radici e orizzonti si incontrano – che valga la pena di essere.