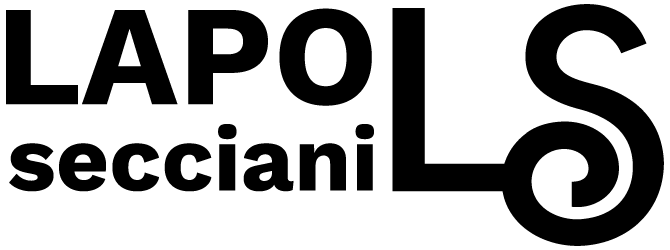C’è qualcosa di profondo, di quasi rivoluzionario, nell’osservare un bambino costruire con i mattoncini LEGO. Non segue un progetto preordinato, non chiede permessi, non teme l’errore.
Sperimenta. Prova, sbaglia, ride.
Impara. E costruisce mondi.
E se fosse proprio questo il modello educativo che manca oggi al lavoro, all’impresa, alla società?
Abbiamo smesso di giocare
Nel passaggio dall’infanzia alla vita adulta, ci siamo convinti che il gioco fosse una perdita di tempo. Che costruire castelli di mattoncini colorati fosse solo un esercizio di fantasia, buono per i bambini.
Era invece molto di più: era allenamento alla complessità, alla collaborazione, alla progettualità senza paura. Era, in fondo, la forma più pura di apprendimento ecocentrico: un atto creativo che tiene conto dell’altro, dello spazio, del contesto.
Ma noi, educati a competere prima ancora che a cooperare, siamo cresciuti in un mondo che premia l’efficienza, il controllo, la performance.
Così – ahimé -ci siamo trasformati in homo ego-centrico, impegnati a scalare piramidi aziendali che somigliano a castelli di carte.
Abbiamo disimparato il gioco, ma con esso abbiamo perso anche la capacità di immaginare.
Quando costruisco, respiro
Io conservo da sempre un amore profondo per i mattoncini LEGO.
Quando mi siedo a costruire, da solo, senza fretta, succede qualcosa che ha poco a che fare con l’infanzia e molto con la consapevolezza.
Il tempo si ferma, il respiro rallenta, la mente si libera. Ogni pezzo si incastra con l’altro, passo dopo passo, e in quell’incastro io mi ritrovo.
Ritrovo una parte mia che spesso dimentico, presa tra responsabilità e obiettivi.
Costruire con i LEGO è per me un gesto semplice e profondamente serio. È una frivolezza necessaria che mi insegna – ogni volta – a essere felice, a scoprire, a divertirmi.
È un atto creativo che mi ricorda che anche nella vita, e nel lavoro, ogni pezzo ha un senso solo se connesso agli altri.
L’impresa come luogo educativo
Adriano Olivetti lo aveva intuito. L’impresa, per essere davvero trasformativa, deve diventare comunità educativa, laboratorio culturale, spazio generativo di senso.
Non basta produrre beni: serve produrre valore umano.
In fondo, che cos’è un’impresa se non un gruppo di persone che – come bambini attorno a un tavolo – si mettono a costruire qualcosa insieme?
Anche Sergio Marchionne, seppure da una prospettiva diversa, ci ha ricordato che la centralità del dovere – non inteso come imposizione esterna ma come responsabilità verso il bene collettivo – è l’unica leva seria per costruire futuro.
Ed è proprio questo il punto: il gioco vero non è evasione.
È esercizio di libertà responsabile. È serietà applicata alla scoperta.
Rigenerare il lavoro, partendo dal gioco
Oggi, nelle aziende, nei cantieri, nei laboratori, serve rimettere al centro il gioco.
Non come divertimento superficiale, ma come modalità relazionale e cognitiva. Il gioco insegna a cooperare, a testare soluzioni, a fallire in fretta, a ricominciare. Insegna la fiducia, l’attenzione all’altro, il pensiero sistemico. Insegna a pensare come un ecosistema.
In una società che ha smarrito il gusto della scoperta, il gioco è atto sovversivo.
È l’antidoto alla burocrazia sterile, alla formazione nozionistica, al management del controllo.
È lo strumento con cui possiamo rigenerare la scuola, l’impresa, la città.
Dall’homo ego-centrico all’homo ECO-centrico
Giocare significa uscire da sé per entrare nel mondo.
Significa accettare che il proprio gesto ha conseguenze, che il proprio mattone si incastra con quello degli altri. È un gesto radicalmente ecocentrico.
Ecco perché serve un nuovo paradigma, capace di integrare l’etica della responsabilità (Marchionne) con l’estetica della comunità (Olivetti).
Un paradigma che trasformi l’impresa in spazio in cui si impara giocando e si lavora creando, dove la produttività è figlia della fiducia, e la competenza nasce dalla curiosità.
Costruire mondi, insieme
Forse è il momento di tornare a costruire castelli.
Non quelli di carta, né quelli di potere.
Ma castelli di immaginazione condivisa, dove la creatività diventa infrastruttura sociale, e il gioco il linguaggio comune.
In un mondo che corre verso il disincanto, l’atto più adulto che possiamo fare è tornare a giocare seriamente.